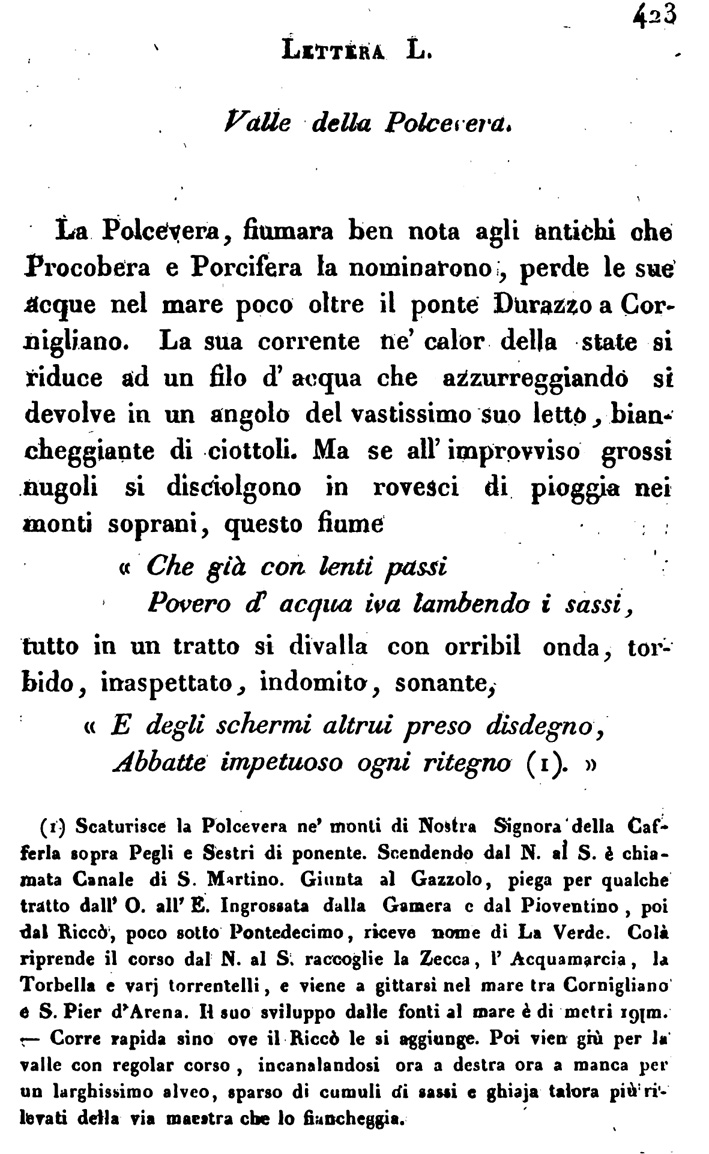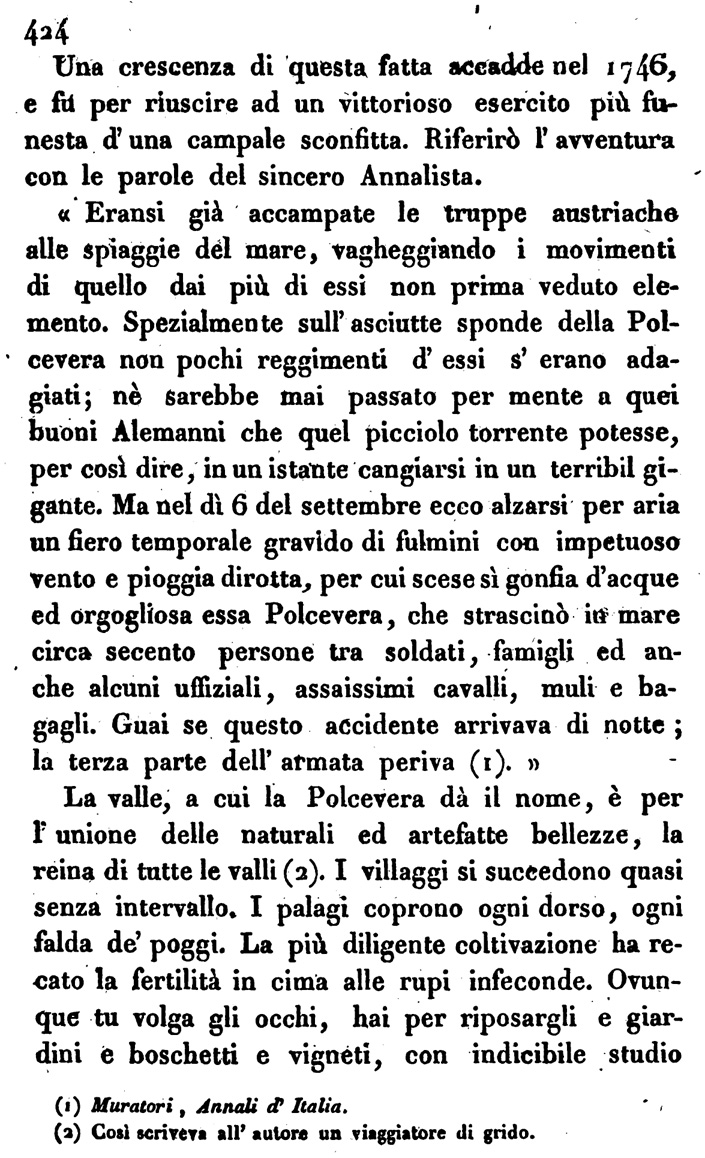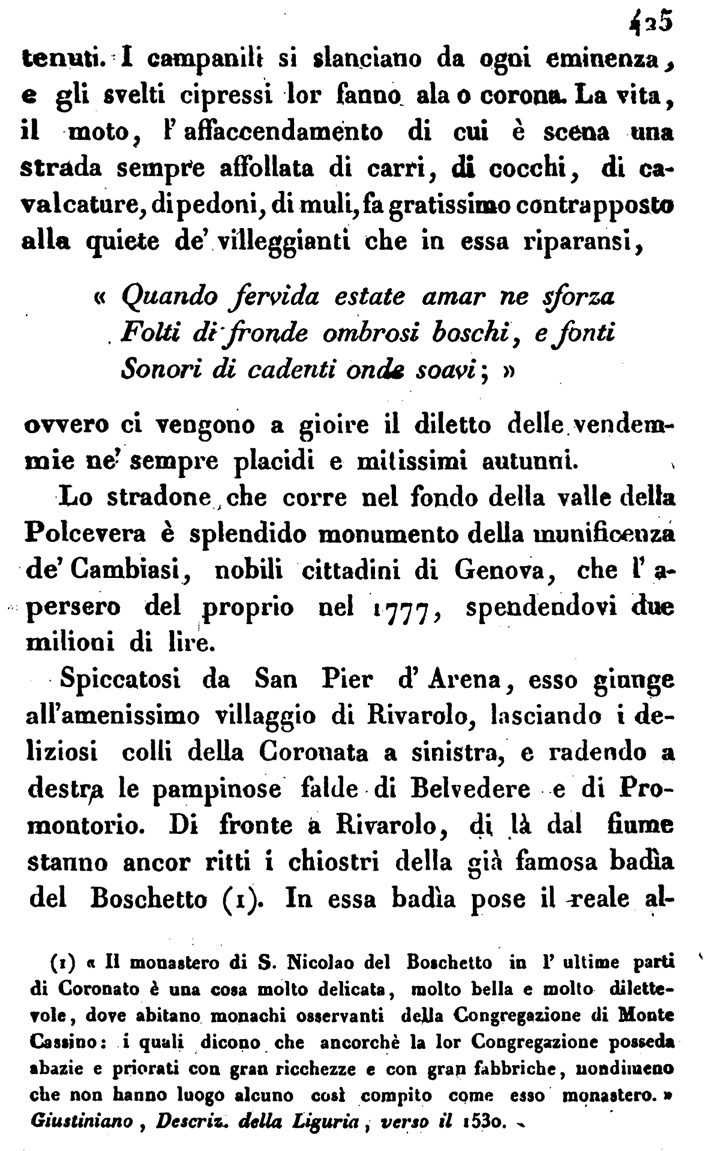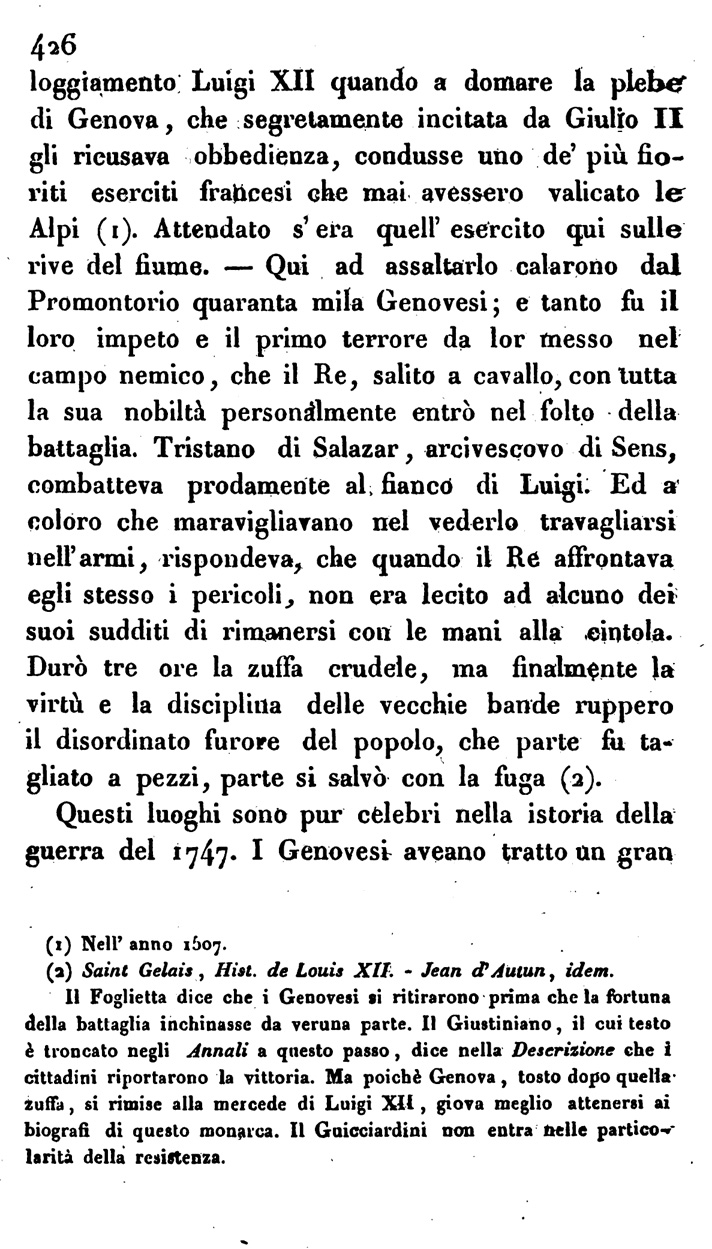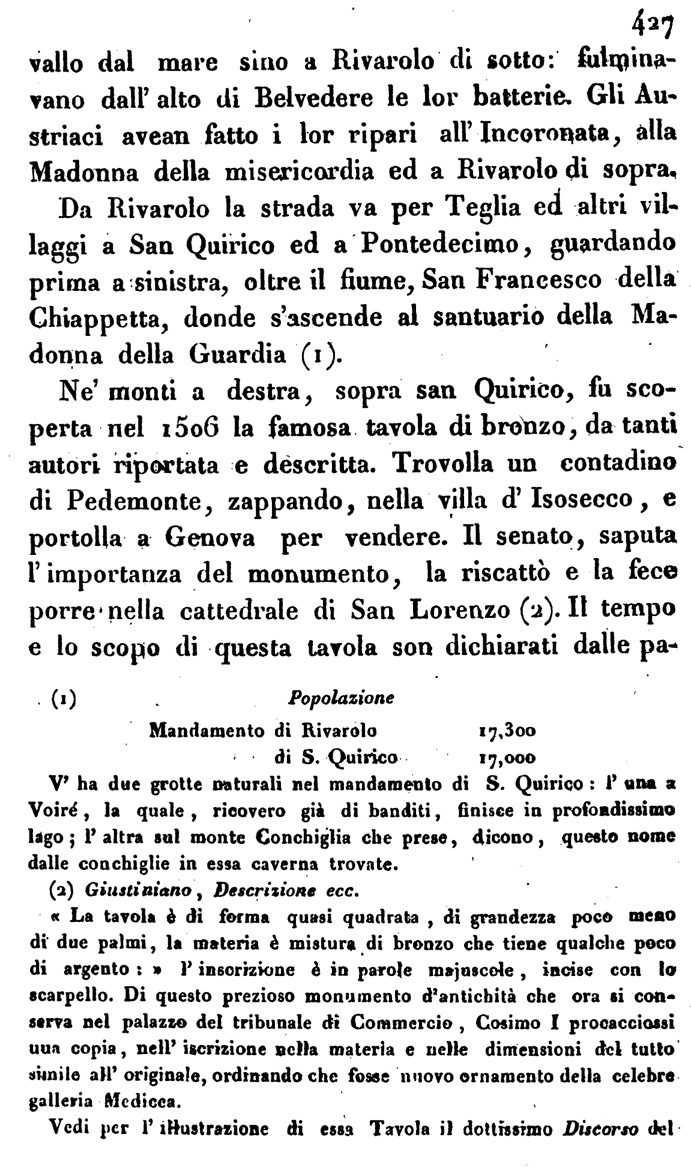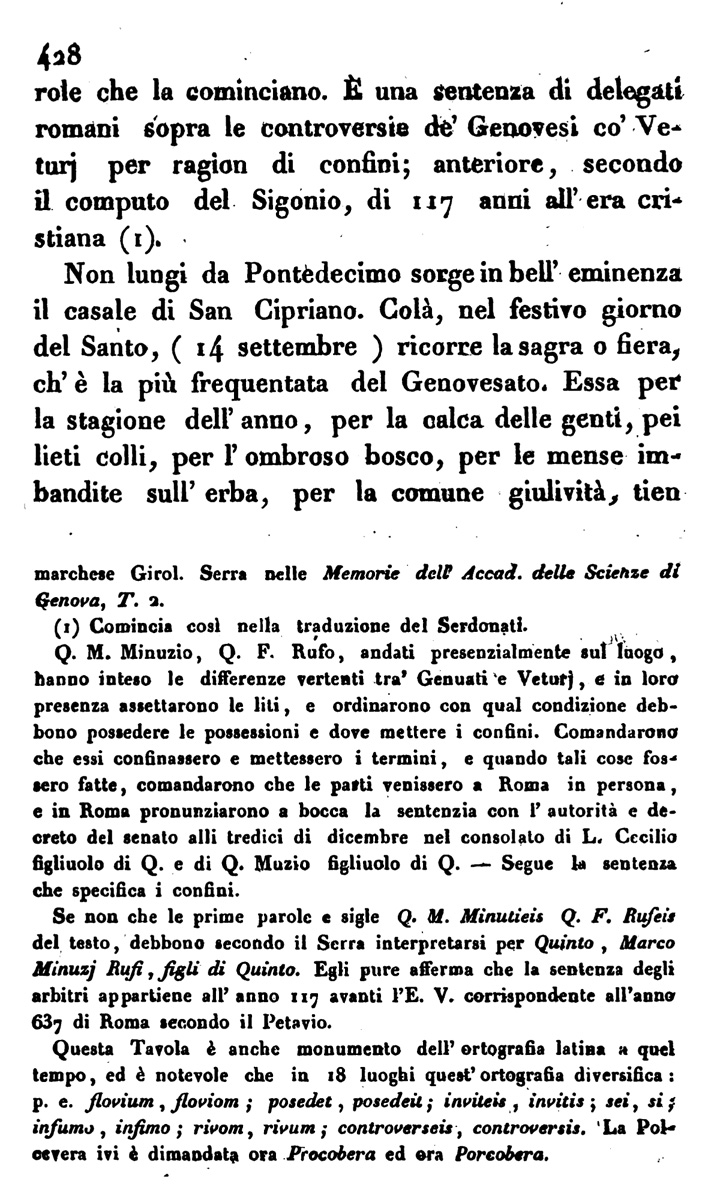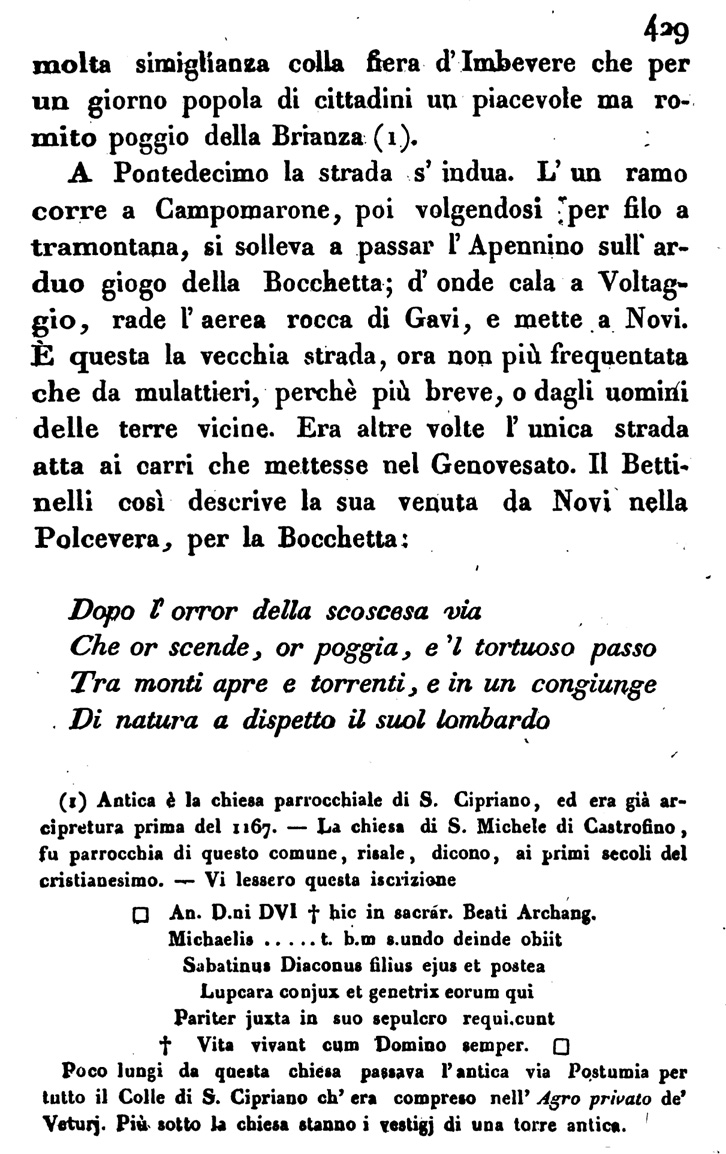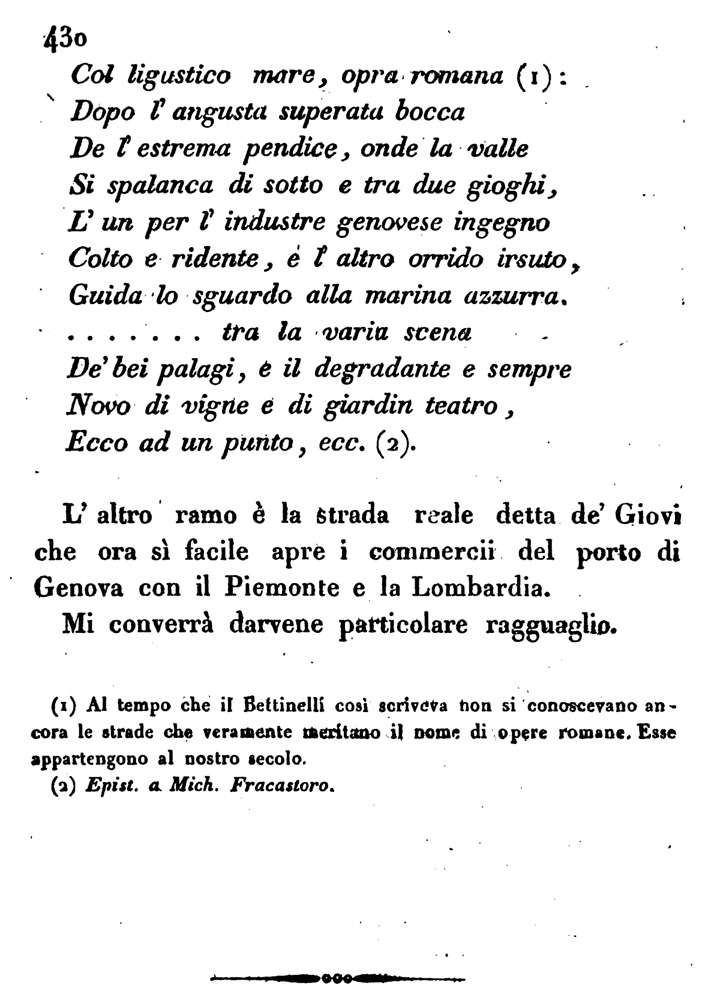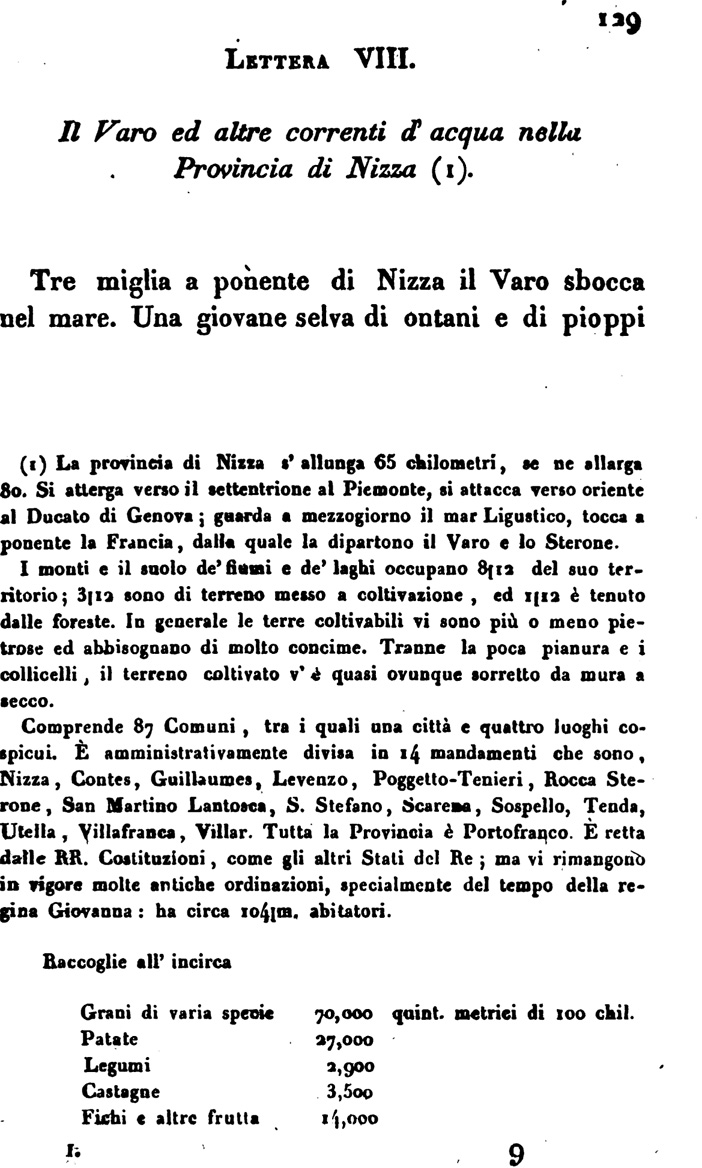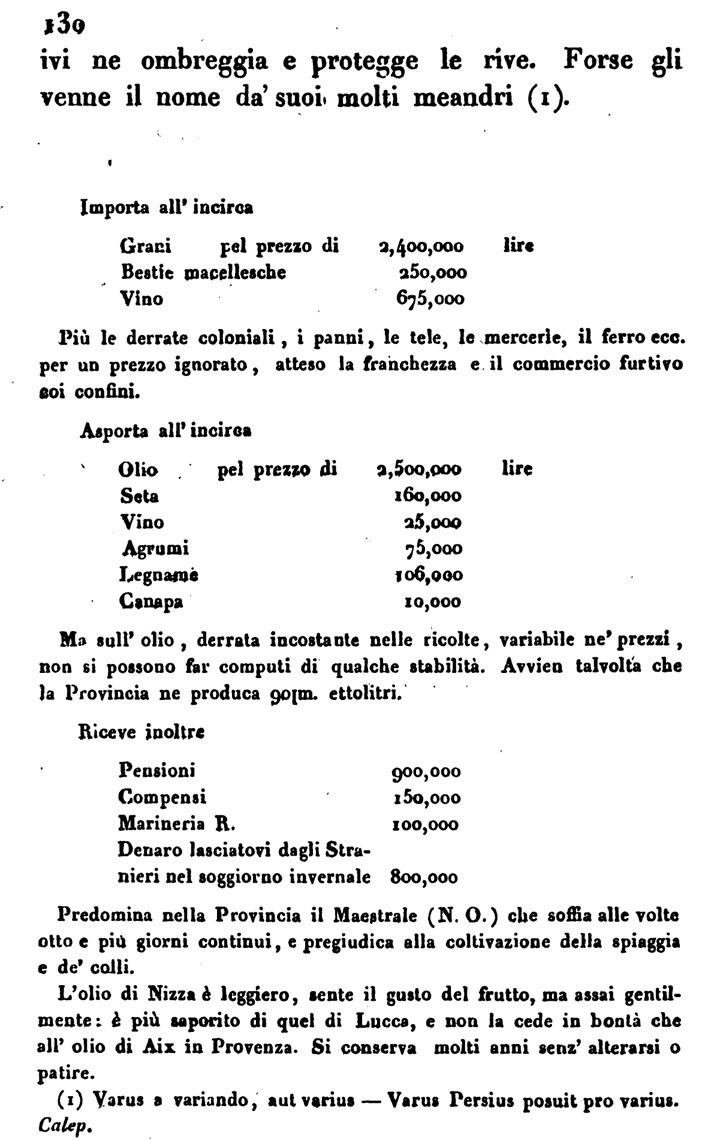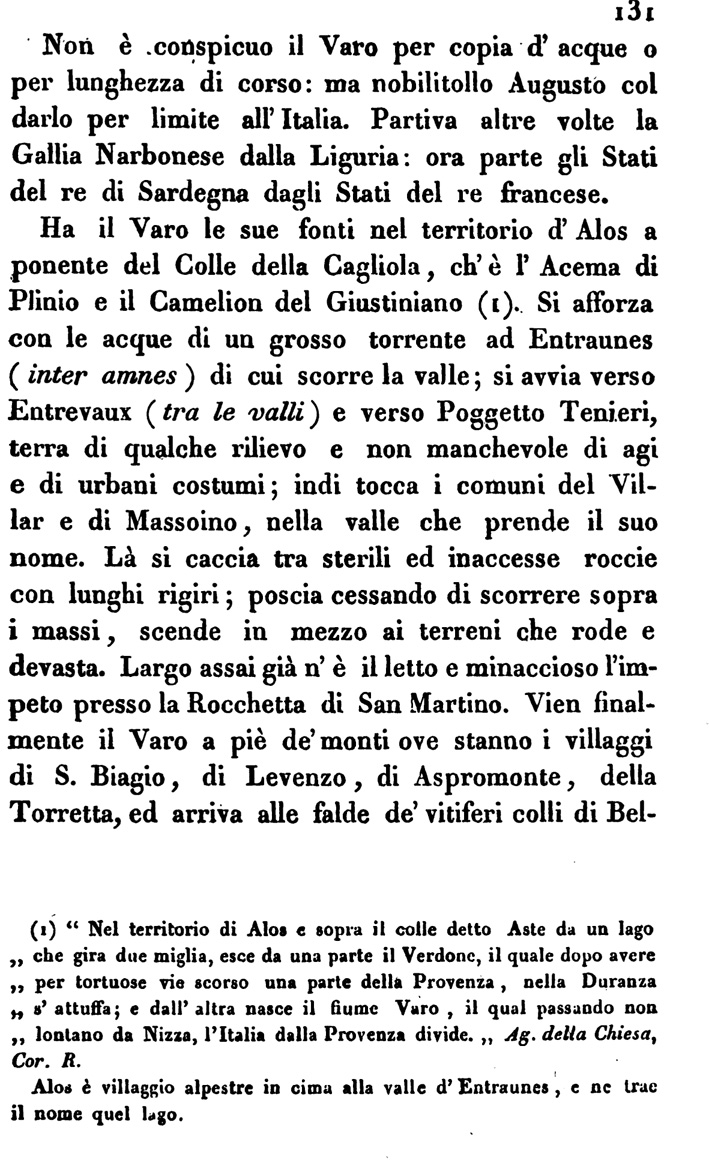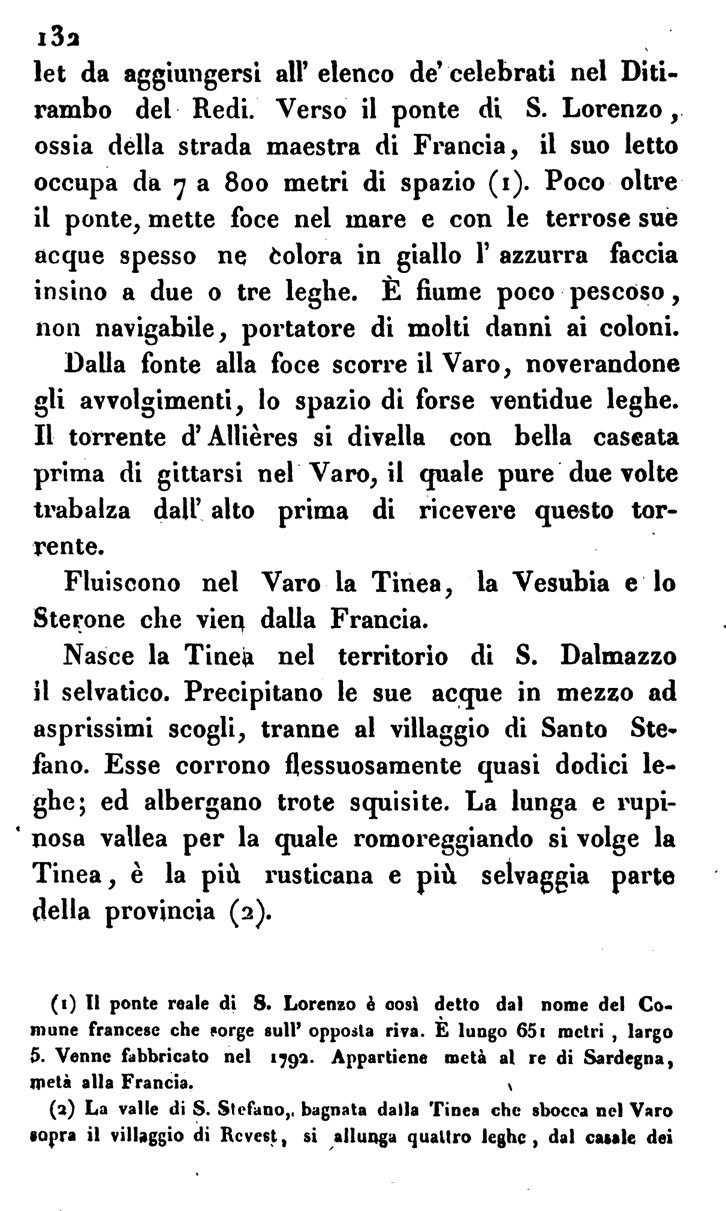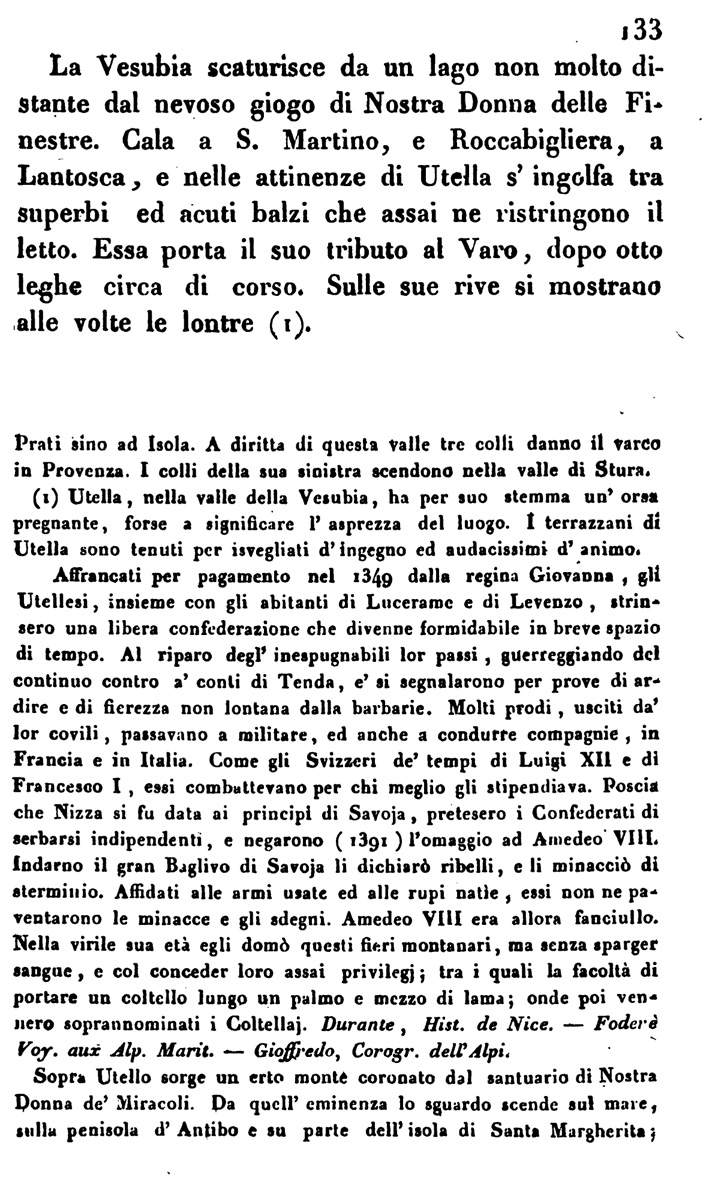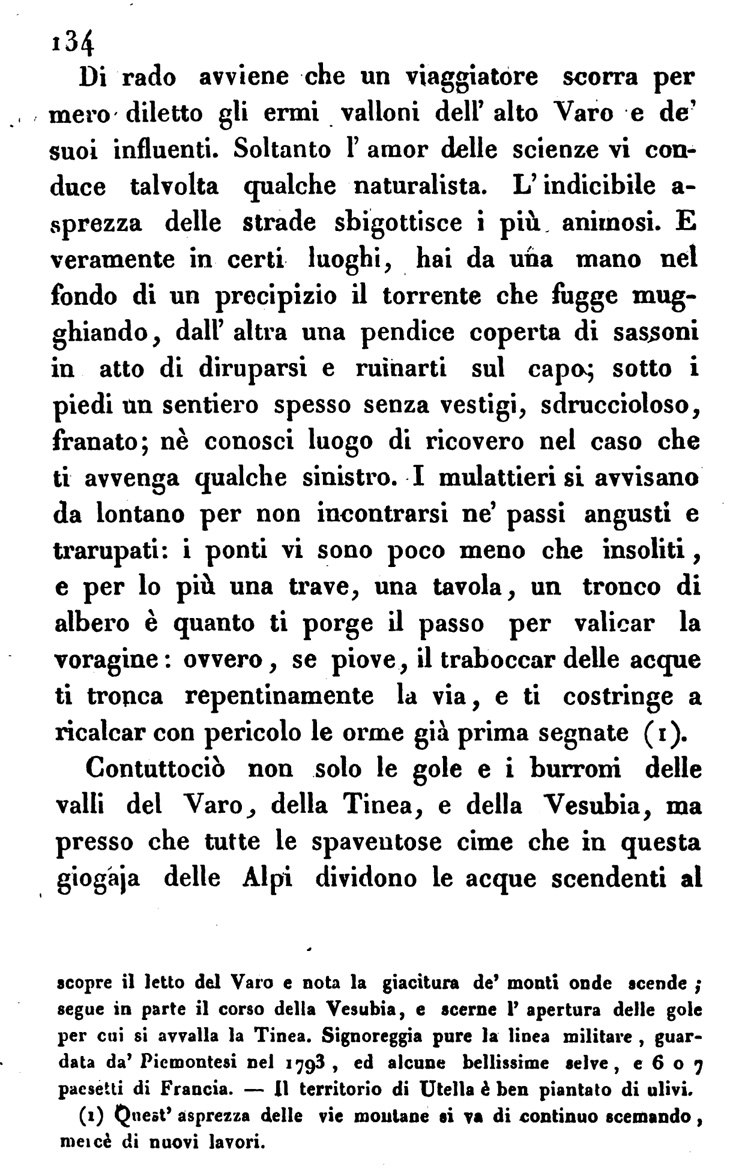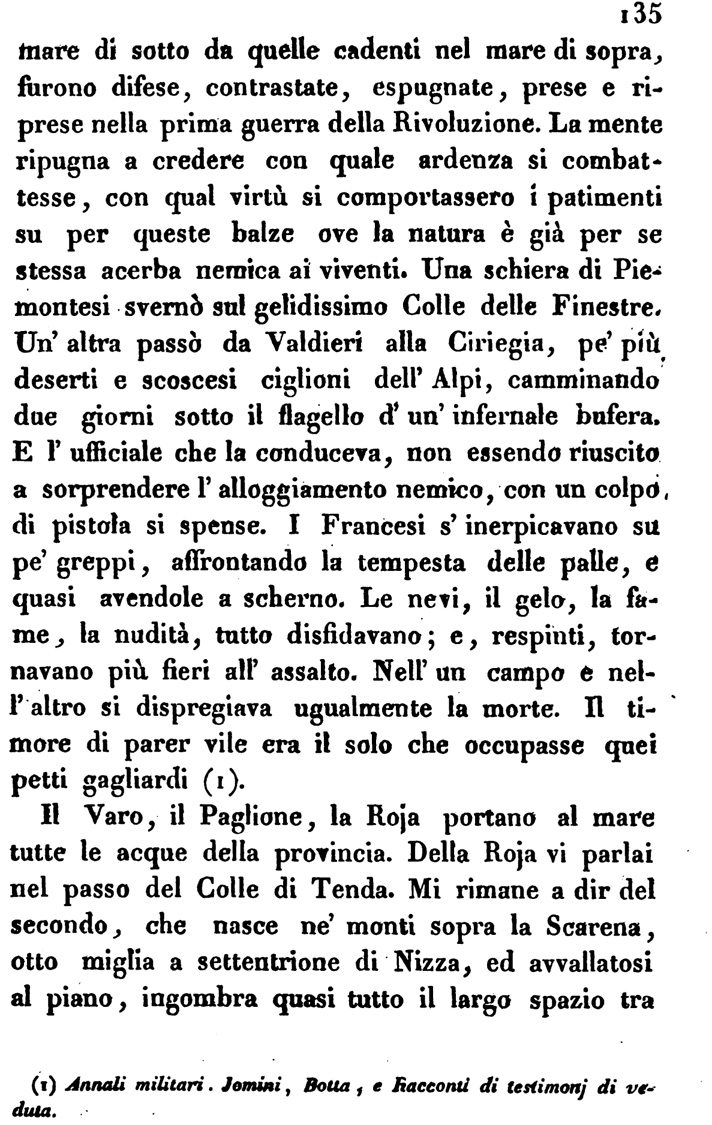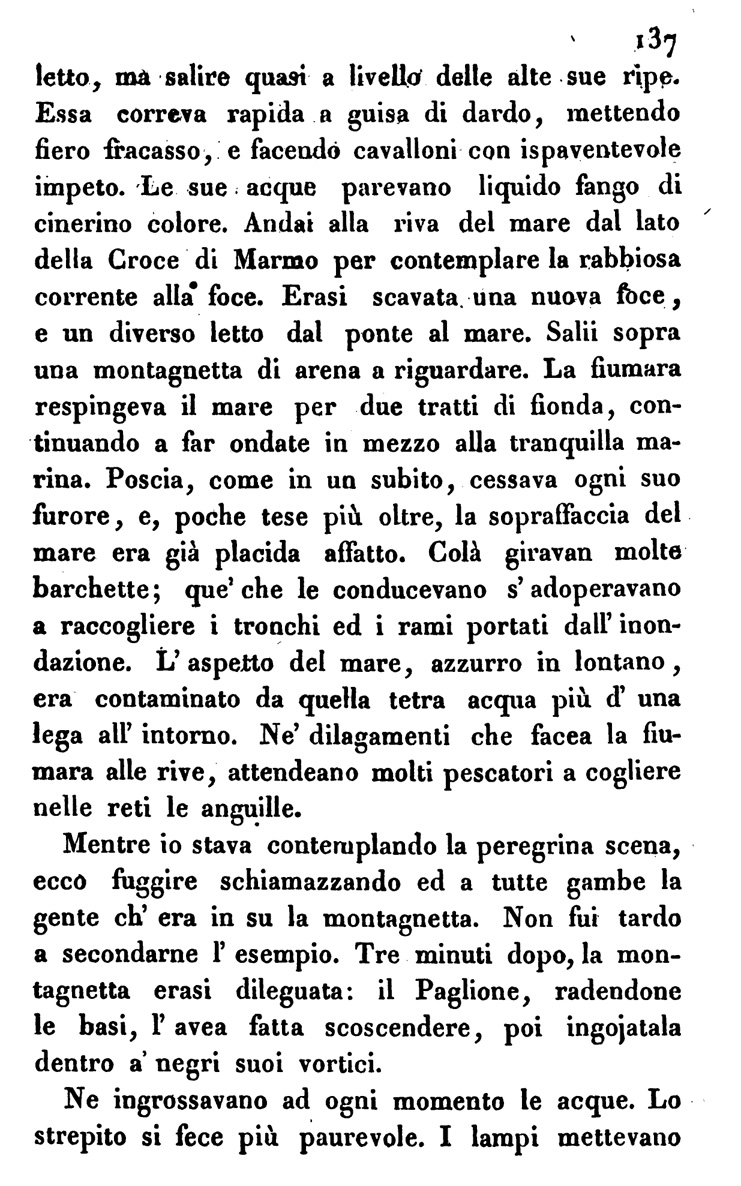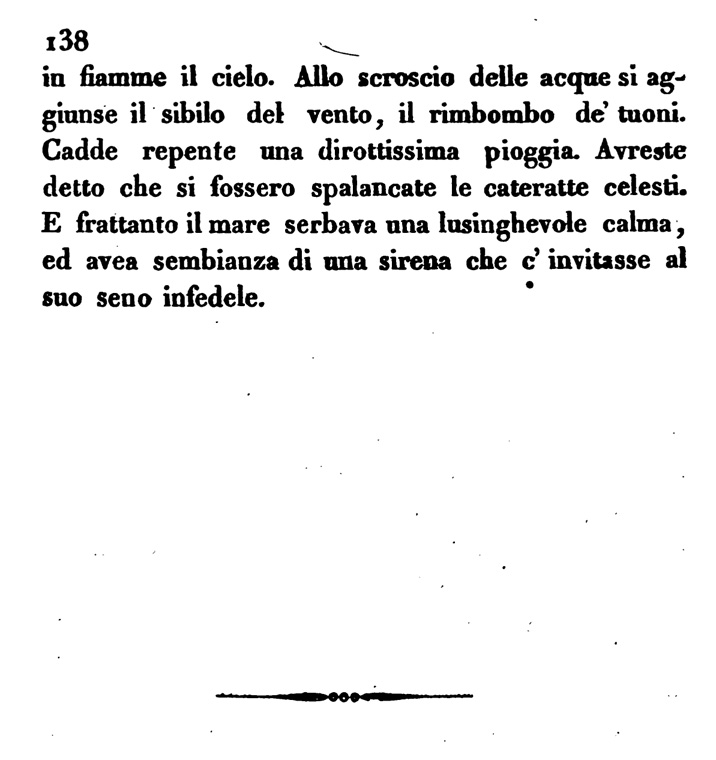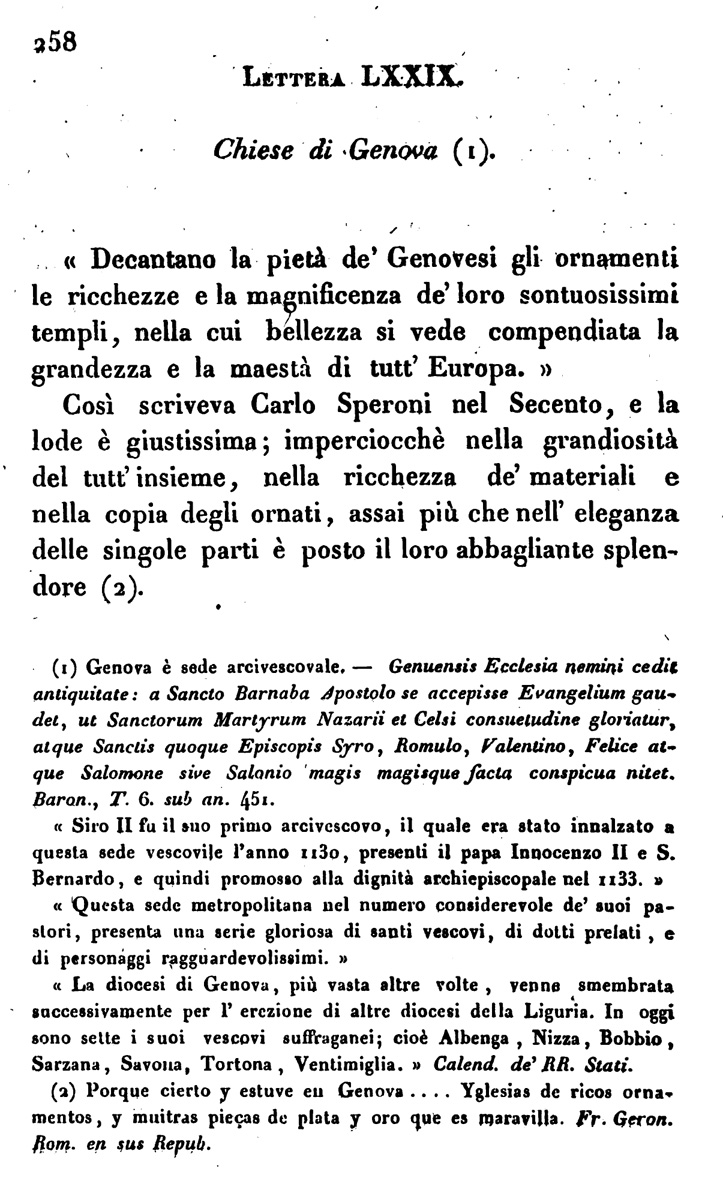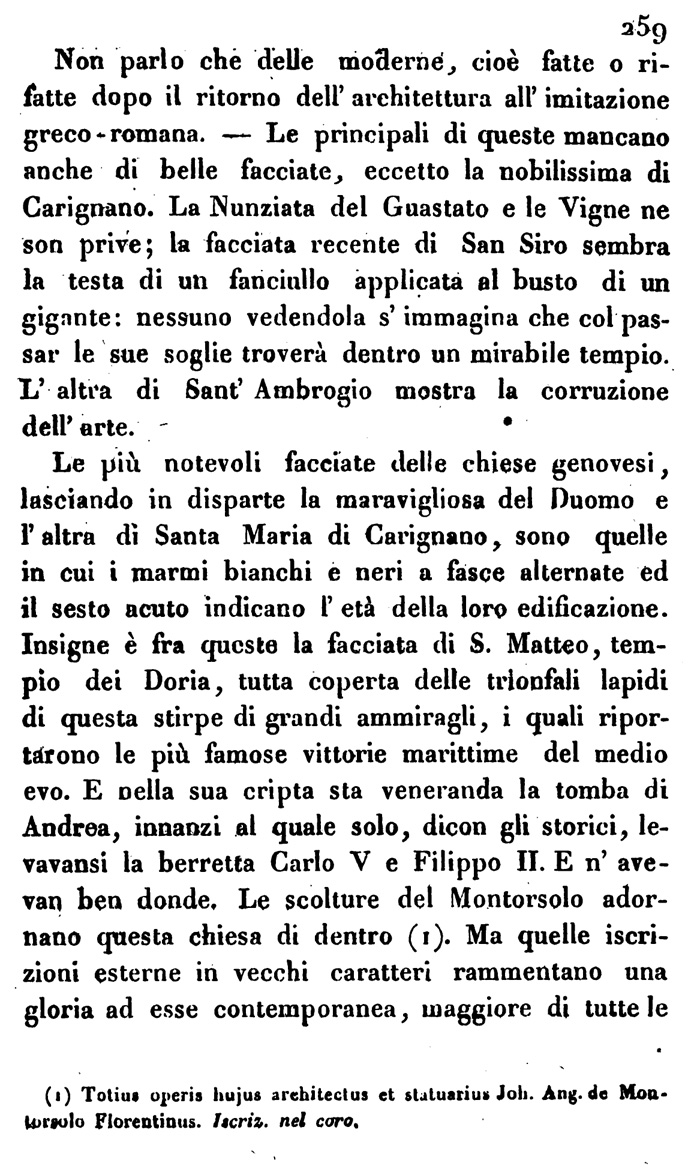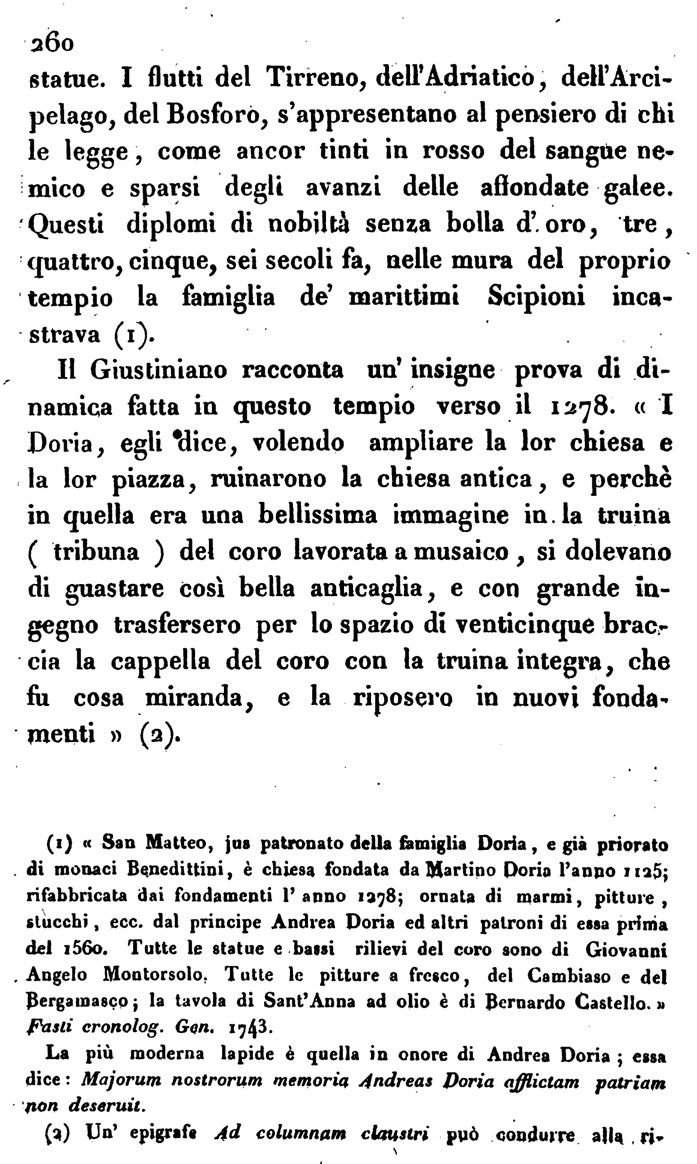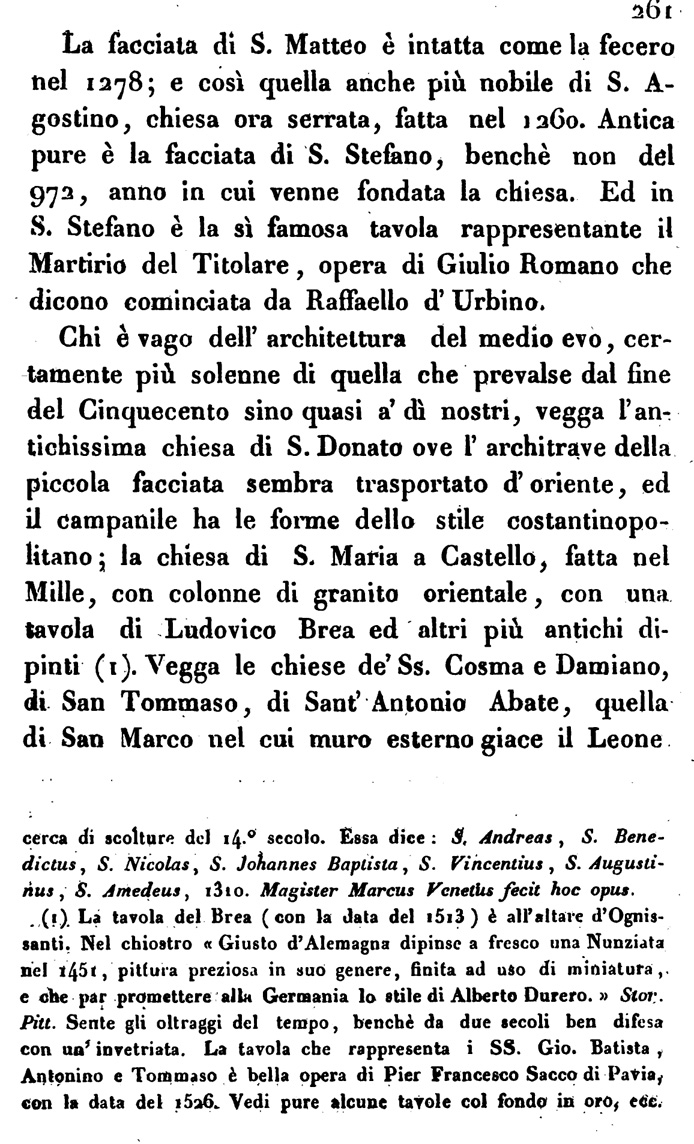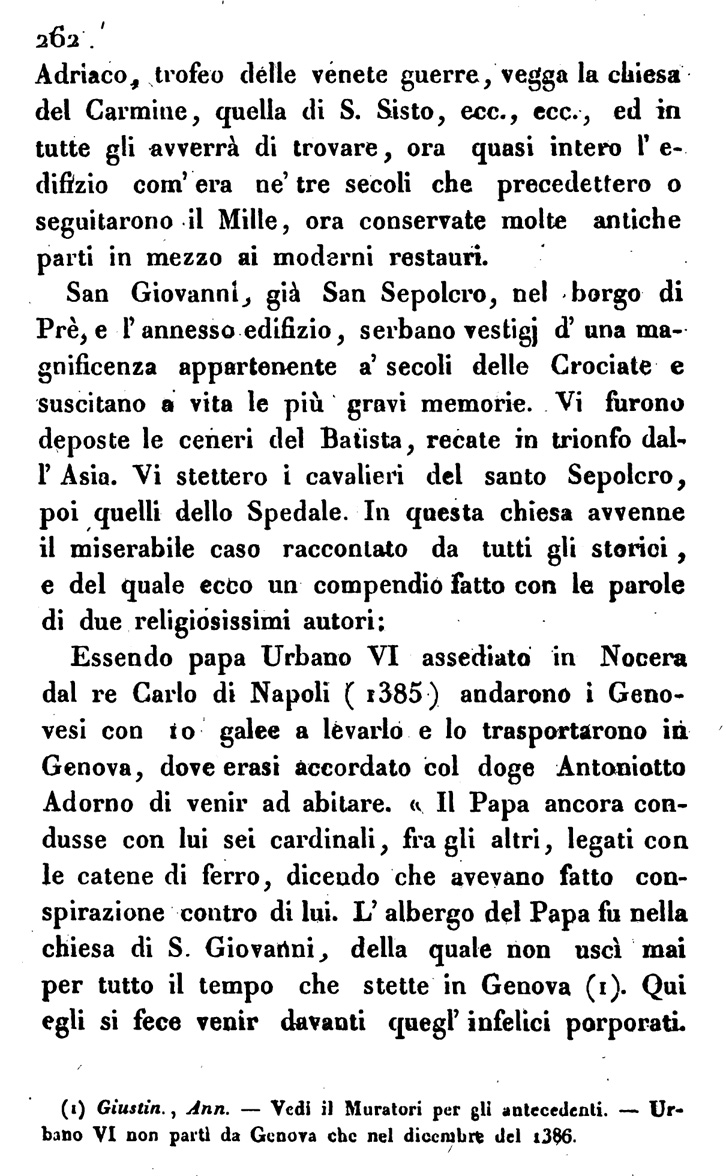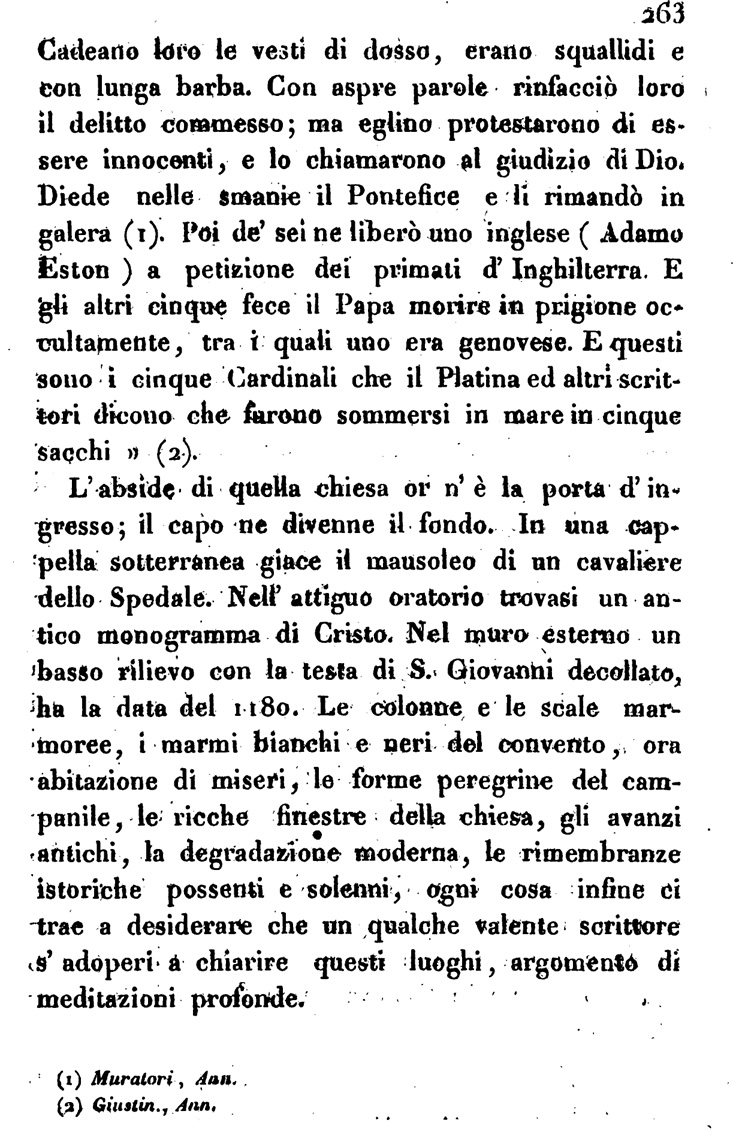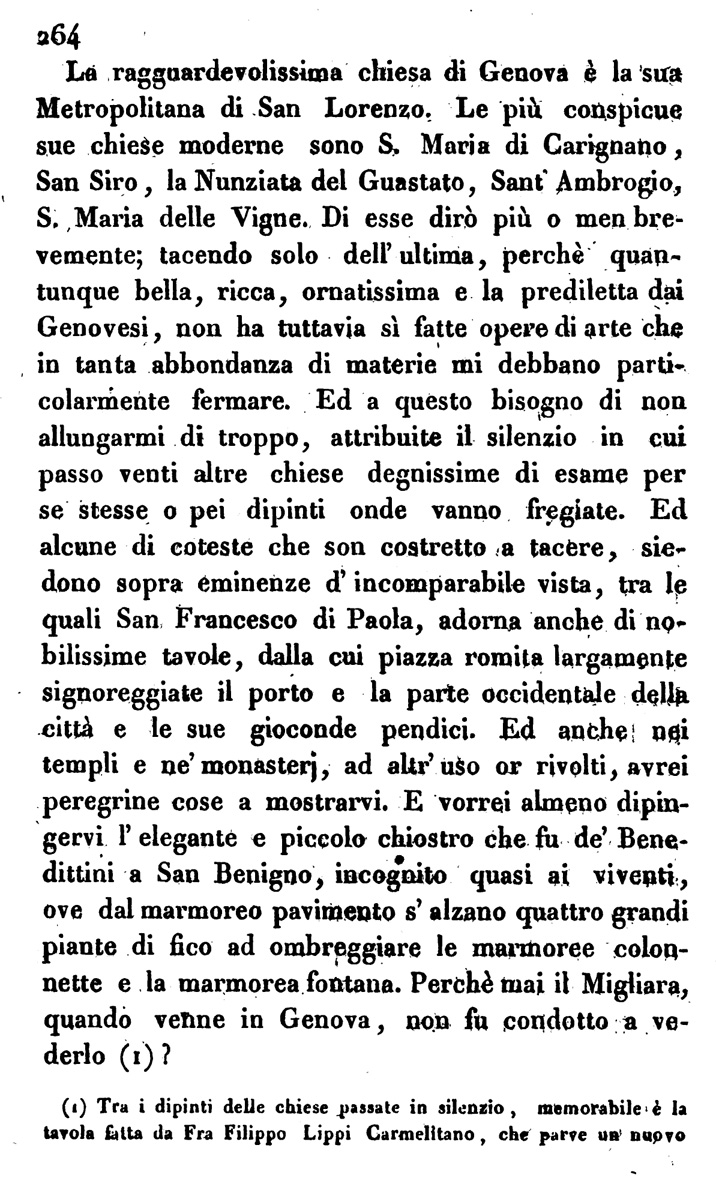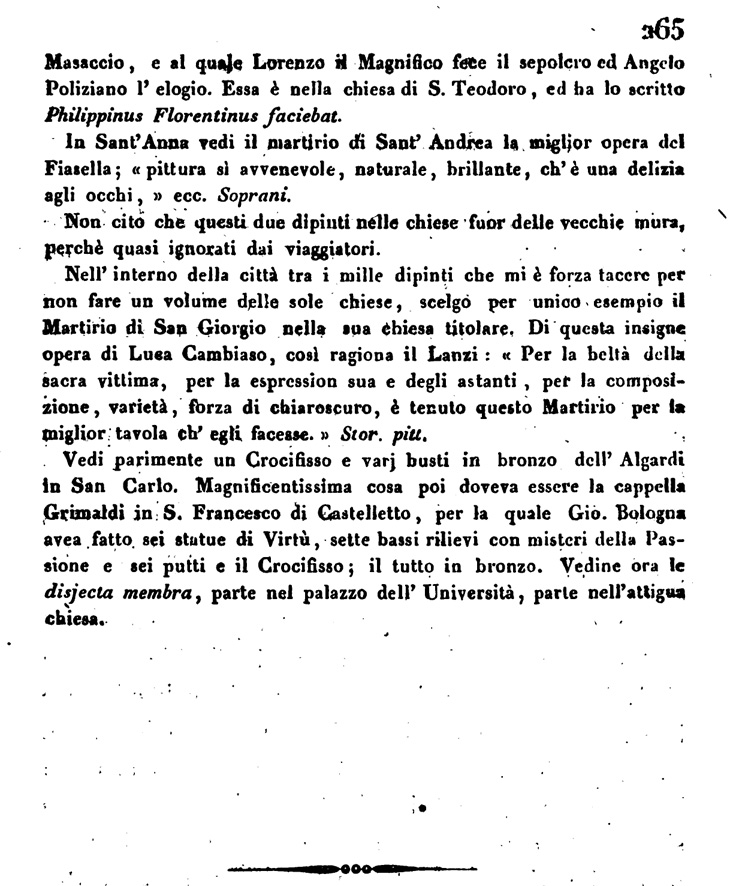La cucina degli antichi romani era assai semplice e con pasti molto frugali: la sua storia sarebbe stata però destinata ad una evoluzione complessa, il cui sostanziale metro di paragone sta nel confronto delle TEORIE GASTRONOMICHE DI CATONE E DI APICIO, come dire tra la semplicità ormai vetusta del primo e la sontuosità alimentare patrocinata dal secondo.
Il nutrimento essenziale era rappresentato dalla polenta di frumento (puls o pulmentus), da legumi (fave, ceci, lenticchie), da farro e da ortaggi.
Nella preparazione della polenta, veniva utilizzato principalmente il farro (far) che era in linea di massima il cereale più coltivato in quel periodo; più tardi vennero utilizzati anche miglio, panico, orzo, la farina di fave o di ceci. In ogni caso il prodotto più utilizzato restava il farro che poteva essere cotto sia in grani interi, sia macinato o frantumato nel mortaio e ridotto in polvere assumendo l'aspetto di ciò che noi chiamiamo farina (da far, farro).
La polenta era preparata in un contenitore di terracotta detto pultarium dove al farro trattato si aggiungeva acqua, sale e un po' di latte e a seconda dei gusti veniva arricchito con fave (puls fabata), cavoli, cipolle, formaggio (puls caseata) ed anche con alcuni pezzi di carne o di pesce; tutto ciò per darle un sapore più ricco, fino ad arrivare ad un vero e proprio miscuglio che conteneva un'infinità di ingredienti chiamato satura o satira ( da cui l'utilizzo moderno di queste due parole: saturazione e satira nel senso di battute o scherzi pesanti), che portava in breve tempo alla sazietà di chi lo mangiava.
Con l'arrivo del pane sulle tavole, la polenta, che era stata l'alimento base per molto tempo, vide diminuire la sua importanza. Vi erano tre tipi di pane: il pane nero o pane dei poveri (panis plebeius o rusticus), il pane bianco anche se poco migliore del primo (panis secundarius) e il pane bianco di farina finissima o pane dei ricchi (panis candidus o mundus); il grano con cui era fatto arrivò ad avere un'importanza primaria, e i Romani arrivarono perfino alla promulgazione di leggi che regolavano la corretta distribuzione di questo prodotto (cura annonae, lex Clodia, lex Sempronia frumentaria); furono organizzati speciali servizi di approvvigionamento, facendo arrivare il grano via mare da zone lontane, depositandolo in magazzini speciali per la successiva distribuzione alla popolazione sotto forma di grano in chicchi oppure come avvenne in un secondo momento, direttamente in pani già cotti.
Il pesce era un cibo molto diffuso, sia di fiume che di mare, sia quello allevato in grandi vivai (vivaria).
I pesci utilizzati nella cucina romana erano di circa 150 specie, si andava da quelli delle tavole dei ricchi (orate, triglie, sogliole, dentici, trote ecc.) a quelli delle tavole dei poveri, più piccoli, di basso prezzo, di solito conservati in salamoia (menae, gerres ecc.).
Molto richiesti erano anche aragoste, polpi, datteri, gamberi e ostriche. Le ostriche (ostrea) che Plinio definiva il "vanto delle mense opulente" erano molto ricercate infatti molti ricchi avevano allevamenti personali, in modo che questo prezioso alimento non mancasse mai alla loro mensa; per questo frutti di mare era stato fabbricato uno speciale cucchiaio a punta (cochler) con cui si aprivano e si vuotavano.
Anche se nella mensa romana erano più frequenti piatti a base di pesce, anche la carne aveva una sua importanza.
Le carni più utilizzate erano quelle di bue e di maiale, ma non era raro trovare anche carne di cervo, di asino selvatico (onager), di cinghiale e di ghiro; di quest'ultimo, molto ricercato nelle tavole dei ricchi, esistevano anche alcuni allevamenti (gliraria) e veniva servito di solito disossato e farcito.
Molto utilizzata anche la carne di uccelli.
Oltre alle specie classiche tuttora utilizzate (tordi, piccioni ecc.), venivano cucinati anche alcuni trampolieri in gran parte importati dalle varie regioni dell'impero, come i fenicotteri (se ne gustava in modo particolare la lingua), le cicogne e le grù.
Piatto molto ricercato era quello a base di carne di pavone e di fagiano.
In quanto al pollo, di cui oggi facciamo molto uso, era considerato carne poco pregiata e la si trovava per lo più nell'alimentazione dei poveri.
La carne veniva cucinata in moltissimi modi: arrosto, in umido e ripiena, con salse di vario genere.
Le uova , di cui si preferiva la chiara al tuorlo, erano come si è detto molto apprezzate come antipasto o consumate rapidamente durante la giornata (Jentaculum e prandium).
Dal latte si ricavavano formaggi freschi e secchi e dolci con aggiunta di miele, farina e frutta; il burro era poco utilizzato in cucina in quanto era usato come medicinale o come unguento per il corpo.
Nelle mense dei ricchi, in occasione di banchetti i piatti di carne o di pesce, venivano preparati nei modi più fantasiosi; era in queste occasioni che i cuochi sfoderavano la loro arte culinaria, servendo in tavola piatti a base di carne camuffati in modo che avessero l'aspetto di uno stupendo pesce alla griglia o sotto forma di vere e proprie sculture a tema mitologico.
Celebri sono i piatti serviti nell'ormai epica cena di Trimalcione, descritta da Petronio nel Satiricon di cui alcuni secoli parla ancora Macrobio.
Fra le più bizzarre elaborazioni culinarie viene menzionata una lepre con le ali disposte in modo da raffigurare Pegaso, il cavallo alato di Bellerofonte, ed una scrofa di cinghiale ripiena di tordi vivi con tanto di cinghialini, fatti di pasta, nell'atto di succhiare alle mammelle della madre.
GARUM: L'arte del saper cucinare non consisteva solo nel saper mascherare l'aspetto di un cibo, ma anche il suo sapore (anche perchè i cuochi dell'epoca non disponendo dei moderni frigoriferi dovevano mascherare il sapore un po rancido di alcuni cibi non proprio freschi), questo veniva ottenuto con l'utilizzo di varie salse composte con ingredienti che avevano poco a che vedere con la pietanza principale del piatto; ad esempio l'aggiunta di salse di pesce o di frutta spiaccicata su ricette a base di carne.
Fra queste la più importante era il garum (dal greco garon che era la specie di pesce utilizzata) o liquamen, una sorta di salsa ottenuta dalla macerazione sotto sale di interiora di pesce con olio, vino, aceto e pepe; lasciata a riposo per una notte in un recipiente di terracotta e messa all'aperto, al sole, per due o tre mesi, rimescolata ogni tanto in modo da farla fermentare; quando la parte liquida si era ridotta per effetto del sole, si inseriva un cestino, il liquido che filtrava era la parte migliore e cioè il garum, la restante parte, lo scarto, era l'allec, la salsa secondaria. Il garum, avrebbe sicuramente avuto, per i nostri gusti, un odore ed un sapore nauseabondo, anche se questo era già riconosciuto da personaggi dell'epoca, infatti Marziale, per descrivere un certo Papilo, un individuo repellente , in uno dei suoi "Epigrammi" dice: "Unguentum fuerat, quod onyx modo parua gerebat: olfecit postquam Papylus, ecce, garumst"(era un unguento profumato quello contenuto fino a poco fa in un vasetto di onice; dopo che l'ha annusato Papilo, ecco, è garum).
Il garum era di solito un liquido chiaro dall'aspetto dorato, che si conservava bene in anfore e veniva utilizzato per aggiungere un gusto saporito alle pietanze; era presente in quasi tutti i piatti e se saputo d osare, faceva la fortuna di molti cuochi.
L'industria del garum era molto sviluppata nel Mediterraneo, quello più pregiato veniva prodotto in Spagna e aveva un prezzo molto elevato, tanto da essere paragonato al più caro dei profumi nonostante il suo acre o dore; veniva importato via mare in anfore con tanto di marchio del produttore e di anno di produzione. Una grande produzione veniva effettuata anche nella nostra penisola, di prim'ordine era quello prodotto a Pompei (officina del garum degli Ombricii).
Il nutrimento essenziale era rappresentato dalla polenta di frumento (puls o pulmentus), da legumi (fave, ceci, lenticchie), da farro e da ortaggi.
Nella preparazione della polenta, veniva utilizzato principalmente il farro (far) che era in linea di massima il cereale più coltivato in quel periodo; più tardi vennero utilizzati anche miglio, panico, orzo, la farina di fave o di ceci. In ogni caso il prodotto più utilizzato restava il farro che poteva essere cotto sia in grani interi, sia macinato o frantumato nel mortaio e ridotto in polvere assumendo l'aspetto di ciò che noi chiamiamo farina (da far, farro).
La polenta era preparata in un contenitore di terracotta detto pultarium dove al farro trattato si aggiungeva acqua, sale e un po' di latte e a seconda dei gusti veniva arricchito con fave (puls fabata), cavoli, cipolle, formaggio (puls caseata) ed anche con alcuni pezzi di carne o di pesce; tutto ciò per darle un sapore più ricco, fino ad arrivare ad un vero e proprio miscuglio che conteneva un'infinità di ingredienti chiamato satura o satira ( da cui l'utilizzo moderno di queste due parole: saturazione e satira nel senso di battute o scherzi pesanti), che portava in breve tempo alla sazietà di chi lo mangiava.
Con l'arrivo del pane sulle tavole, la polenta, che era stata l'alimento base per molto tempo, vide diminuire la sua importanza. Vi erano tre tipi di pane: il pane nero o pane dei poveri (panis plebeius o rusticus), il pane bianco anche se poco migliore del primo (panis secundarius) e il pane bianco di farina finissima o pane dei ricchi (panis candidus o mundus); il grano con cui era fatto arrivò ad avere un'importanza primaria, e i Romani arrivarono perfino alla promulgazione di leggi che regolavano la corretta distribuzione di questo prodotto (cura annonae, lex Clodia, lex Sempronia frumentaria); furono organizzati speciali servizi di approvvigionamento, facendo arrivare il grano via mare da zone lontane, depositandolo in magazzini speciali per la successiva distribuzione alla popolazione sotto forma di grano in chicchi oppure come avvenne in un secondo momento, direttamente in pani già cotti.
Il pesce era un cibo molto diffuso, sia di fiume che di mare, sia quello allevato in grandi vivai (vivaria).
I pesci utilizzati nella cucina romana erano di circa 150 specie, si andava da quelli delle tavole dei ricchi (orate, triglie, sogliole, dentici, trote ecc.) a quelli delle tavole dei poveri, più piccoli, di basso prezzo, di solito conservati in salamoia (menae, gerres ecc.).
Molto richiesti erano anche aragoste, polpi, datteri, gamberi e ostriche. Le ostriche (ostrea) che Plinio definiva il "vanto delle mense opulente" erano molto ricercate infatti molti ricchi avevano allevamenti personali, in modo che questo prezioso alimento non mancasse mai alla loro mensa; per questo frutti di mare era stato fabbricato uno speciale cucchiaio a punta (cochler) con cui si aprivano e si vuotavano.
Anche se nella mensa romana erano più frequenti piatti a base di pesce, anche la carne aveva una sua importanza.
Le carni più utilizzate erano quelle di bue e di maiale, ma non era raro trovare anche carne di cervo, di asino selvatico (onager), di cinghiale e di ghiro; di quest'ultimo, molto ricercato nelle tavole dei ricchi, esistevano anche alcuni allevamenti (gliraria) e veniva servito di solito disossato e farcito.
Molto utilizzata anche la carne di uccelli.
Oltre alle specie classiche tuttora utilizzate (tordi, piccioni ecc.), venivano cucinati anche alcuni trampolieri in gran parte importati dalle varie regioni dell'impero, come i fenicotteri (se ne gustava in modo particolare la lingua), le cicogne e le grù.
Piatto molto ricercato era quello a base di carne di pavone e di fagiano.
In quanto al pollo, di cui oggi facciamo molto uso, era considerato carne poco pregiata e la si trovava per lo più nell'alimentazione dei poveri.
La carne veniva cucinata in moltissimi modi: arrosto, in umido e ripiena, con salse di vario genere.
Le uova , di cui si preferiva la chiara al tuorlo, erano come si è detto molto apprezzate come antipasto o consumate rapidamente durante la giornata (Jentaculum e prandium).
Dal latte si ricavavano formaggi freschi e secchi e dolci con aggiunta di miele, farina e frutta; il burro era poco utilizzato in cucina in quanto era usato come medicinale o come unguento per il corpo.
Nelle mense dei ricchi, in occasione di banchetti i piatti di carne o di pesce, venivano preparati nei modi più fantasiosi; era in queste occasioni che i cuochi sfoderavano la loro arte culinaria, servendo in tavola piatti a base di carne camuffati in modo che avessero l'aspetto di uno stupendo pesce alla griglia o sotto forma di vere e proprie sculture a tema mitologico.
Celebri sono i piatti serviti nell'ormai epica cena di Trimalcione, descritta da Petronio nel Satiricon di cui alcuni secoli parla ancora Macrobio.
Fra le più bizzarre elaborazioni culinarie viene menzionata una lepre con le ali disposte in modo da raffigurare Pegaso, il cavallo alato di Bellerofonte, ed una scrofa di cinghiale ripiena di tordi vivi con tanto di cinghialini, fatti di pasta, nell'atto di succhiare alle mammelle della madre.
GARUM: L'arte del saper cucinare non consisteva solo nel saper mascherare l'aspetto di un cibo, ma anche il suo sapore (anche perchè i cuochi dell'epoca non disponendo dei moderni frigoriferi dovevano mascherare il sapore un po rancido di alcuni cibi non proprio freschi), questo veniva ottenuto con l'utilizzo di varie salse composte con ingredienti che avevano poco a che vedere con la pietanza principale del piatto; ad esempio l'aggiunta di salse di pesce o di frutta spiaccicata su ricette a base di carne.
Fra queste la più importante era il garum (dal greco garon che era la specie di pesce utilizzata) o liquamen, una sorta di salsa ottenuta dalla macerazione sotto sale di interiora di pesce con olio, vino, aceto e pepe; lasciata a riposo per una notte in un recipiente di terracotta e messa all'aperto, al sole, per due o tre mesi, rimescolata ogni tanto in modo da farla fermentare; quando la parte liquida si era ridotta per effetto del sole, si inseriva un cestino, il liquido che filtrava era la parte migliore e cioè il garum, la restante parte, lo scarto, era l'allec, la salsa secondaria. Il garum, avrebbe sicuramente avuto, per i nostri gusti, un odore ed un sapore nauseabondo, anche se questo era già riconosciuto da personaggi dell'epoca, infatti Marziale, per descrivere un certo Papilo, un individuo repellente , in uno dei suoi "Epigrammi" dice: "Unguentum fuerat, quod onyx modo parua gerebat: olfecit postquam Papylus, ecce, garumst"(era un unguento profumato quello contenuto fino a poco fa in un vasetto di onice; dopo che l'ha annusato Papilo, ecco, è garum).
Il garum era di solito un liquido chiaro dall'aspetto dorato, che si conservava bene in anfore e veniva utilizzato per aggiungere un gusto saporito alle pietanze; era presente in quasi tutti i piatti e se saputo d osare, faceva la fortuna di molti cuochi.
L'industria del garum era molto sviluppata nel Mediterraneo, quello più pregiato veniva prodotto in Spagna e aveva un prezzo molto elevato, tanto da essere paragonato al più caro dei profumi nonostante il suo acre o dore; veniva importato via mare in anfore con tanto di marchio del produttore e di anno di produzione. Una grande produzione veniva effettuata anche nella nostra penisola, di prim'ordine era quello prodotto a Pompei (officina del garum degli Ombricii).
FRUTTA E VERDURE: Per quanto riguarda le verdure, si consumavano: lenticchie, fave, ceci, piselli, lattughe, cavoli, carote, rape, cipolle, zucche, carciofi e asparagi (più rari), cetrioli, erbe lassative come malve e bietole, menta e funghi (boleti) i quali erano molto ricercati.
Le olive erano sempre presenti sia sulle tavole dei ricchi che su quelle dei poveri.
L'olio di oliva fu una delle maggiori componenti dell'alimentazione dei Romani, usato anche per la medicina e per l'illuminazione; se ne trovava di varie qualità: L'olio vergine di prima spremitura (oleum flos), l'olio di seconda qualità (oleum sequens) e l'olio comunemente usato (oleum cibarium). Il consumo medio di olio di un cittadino romano era di circa 2 litri in un mese: Roma faceva la parte del leone in quanto è stato verificato che il Monte Testaccio ( un'autentica montagna artificiale formata da frammenti di anfore) è composta essenzialmente da resti di anfore olearie, in gran parte provenienti dalla regione della Betica (Spagna meridionale) che era il più grande esportatore di olio dell'epoca.
La frutta era costituita da mele (mala), pere (pira), ciliege (cerasa), susine (pruna), noci, mandorle (nux amygdala), castagne, uva (fresca e passa) e pesche.
Dall'Armenia giungevano le albicocche che venivano utilizzate spesso spiaccicate, ricavandone una salsa che accompagnava molti piatti di carne.
Dall'Africa arrivavano i datteri (dactyli).
La frutta oltre che consumata fresca veniva utilizzata anche per ricavarne marmellate ed era un componente importante per la preparazione di dolci.
Le olive erano sempre presenti sia sulle tavole dei ricchi che su quelle dei poveri.
L'olio di oliva fu una delle maggiori componenti dell'alimentazione dei Romani, usato anche per la medicina e per l'illuminazione; se ne trovava di varie qualità: L'olio vergine di prima spremitura (oleum flos), l'olio di seconda qualità (oleum sequens) e l'olio comunemente usato (oleum cibarium). Il consumo medio di olio di un cittadino romano era di circa 2 litri in un mese: Roma faceva la parte del leone in quanto è stato verificato che il Monte Testaccio ( un'autentica montagna artificiale formata da frammenti di anfore) è composta essenzialmente da resti di anfore olearie, in gran parte provenienti dalla regione della Betica (Spagna meridionale) che era il più grande esportatore di olio dell'epoca.
La frutta era costituita da mele (mala), pere (pira), ciliege (cerasa), susine (pruna), noci, mandorle (nux amygdala), castagne, uva (fresca e passa) e pesche.
Dall'Armenia giungevano le albicocche che venivano utilizzate spesso spiaccicate, ricavandone una salsa che accompagnava molti piatti di carne.
Dall'Africa arrivavano i datteri (dactyli).
La frutta oltre che consumata fresca veniva utilizzata anche per ricavarne marmellate ed era un componente importante per la preparazione di dolci.
Il VINO aveva un'importanza particolare per i Romani in quanto era la bevanda più amata e concludeva tutte le cene.
Veniva prodotta sia la qualità rossa (vinum atrum), sia la qualità bianca (vinum candidum), era commerciato in larga scala e addirittura si formarono anche alcune cooperative per la vendita di questa bevanda ( collegia); a Roma è stata verificata l'esistenza di un porto e di un mercato attrezzati essenzialmente per la vendita del vino ( portum vinarium e forum vinarium).
Il vino era raramente limpido e veniva di solito filtrato con un passino (colum), si beveva quasi sempre allungato con acqua calda o fredda (in inverno a volte anche con neve) in modo da ridurne la gradazione alcolica di solito da 15/16 a 5/6 gradi.
I tipi più pregiati erano il Massico e il Falerno (dalla Campania), il Cecubo, il Volturno, l' Albano e il Sabino (dal Lazio) e il Setino; i più scadenti erano il Veietano (come tutti i vini dell'Etruria era considerato di qualità scadente), quello del Vaticano e quello di Marsiglia ( i vini della Gallia narbonese venivano affumicati e spesso contraffatti ).
Esistevano anche vini resinati, ma considerati di cattiva qualità in quanto la resina si aggiungeva ai vini più scadenti in modo che si conservassero più a lungo.
Sulle anfore utilizzate per il trasporto era impressa in una targhetta (pittacium) l'origine e la data di produzione per tutelare l'acquirente, anche se già in quell'epoca esistevano casi di adulterazione (cosa non rara: per esempio in una ricetta di Apicio si insegna a trasformare il vino rosso in bianco.
I vini aromatizzati sono indicati sotto il nome di Aromatites, di Mirris, uno dei più apprezzati.
Si aveva infatti l'abitudine di fare un vino aromatico, preparato all'incirca come i profumi, prima con mirra poi canna, giunco, cannella, zafferano e palma.
Il Gustaticium era un vino aperitivo da assaporare prima del pasto e che si addollciva con l'aggiunta di miele.
Infine erano ricchi di vini medicinali, si mescolava vino e miele e il prodotto era chiamato Mulsum.
Il Passum era un vino fatto con uve secche ma che serviva per i malati.
Certe famiglie pompeiane si erano specializzate nella viticoltura e facevano invecchiare nelle cantine le anfore di mulsum.I vini invecchiati (quelli che avevano passato l'estate successiva alla data di produzione) erano di grande pregio sulle tavole dei ricchi Romani, i quali li ostentavano nei loro banchetti.
Esistevano anche surrogati del vino come la lora, ottenuta dalla fermentazione delle vinacce con acqua subito dopo la vendemmia e la posca, formata da acqua e vino inacidito (acetum).
Il consumo del vino ebbe la sua espansione in epoca imperiale per lo più nelle zone di produzione e nelle grandi città come Roma dove per le enormi esigenze dovute all'alta densità della popolazione portarono anche ad una distribuzione gratuita di questa bevanda (imperatore Aureliano, ultimi decenni del III sec. d.C.) e al conseguente afflusso di grandi quantità di vino sia italico che di importazione. I prezzi andavano dai 30 denari al sestiario (0,54 l) per i vini pregiati (Falernum, Sorrentinum, Tiburtinum), ai 16 denari al sestiario per i vini di media qualità, agli 8 denari per i vini di basso pregio.
Il consumo medio di vino in un anno è stato calcolato in 140 - 180 litri a persona: questo grande consumo si pensa fosse dovuto anche al grande apporto calorifero che dava alla dieta romana, costituita in gran parte da cereali e vegetali.
Veniva prodotta sia la qualità rossa (vinum atrum), sia la qualità bianca (vinum candidum), era commerciato in larga scala e addirittura si formarono anche alcune cooperative per la vendita di questa bevanda ( collegia); a Roma è stata verificata l'esistenza di un porto e di un mercato attrezzati essenzialmente per la vendita del vino ( portum vinarium e forum vinarium).
Il vino era raramente limpido e veniva di solito filtrato con un passino (colum), si beveva quasi sempre allungato con acqua calda o fredda (in inverno a volte anche con neve) in modo da ridurne la gradazione alcolica di solito da 15/16 a 5/6 gradi.
I tipi più pregiati erano il Massico e il Falerno (dalla Campania), il Cecubo, il Volturno, l' Albano e il Sabino (dal Lazio) e il Setino; i più scadenti erano il Veietano (come tutti i vini dell'Etruria era considerato di qualità scadente), quello del Vaticano e quello di Marsiglia ( i vini della Gallia narbonese venivano affumicati e spesso contraffatti ).
Esistevano anche vini resinati, ma considerati di cattiva qualità in quanto la resina si aggiungeva ai vini più scadenti in modo che si conservassero più a lungo.
Sulle anfore utilizzate per il trasporto era impressa in una targhetta (pittacium) l'origine e la data di produzione per tutelare l'acquirente, anche se già in quell'epoca esistevano casi di adulterazione (cosa non rara: per esempio in una ricetta di Apicio si insegna a trasformare il vino rosso in bianco.
I vini aromatizzati sono indicati sotto il nome di Aromatites, di Mirris, uno dei più apprezzati.
Si aveva infatti l'abitudine di fare un vino aromatico, preparato all'incirca come i profumi, prima con mirra poi canna, giunco, cannella, zafferano e palma.
Il Gustaticium era un vino aperitivo da assaporare prima del pasto e che si addollciva con l'aggiunta di miele.
Infine erano ricchi di vini medicinali, si mescolava vino e miele e il prodotto era chiamato Mulsum.
Il Passum era un vino fatto con uve secche ma che serviva per i malati.
Certe famiglie pompeiane si erano specializzate nella viticoltura e facevano invecchiare nelle cantine le anfore di mulsum.I vini invecchiati (quelli che avevano passato l'estate successiva alla data di produzione) erano di grande pregio sulle tavole dei ricchi Romani, i quali li ostentavano nei loro banchetti.
Esistevano anche surrogati del vino come la lora, ottenuta dalla fermentazione delle vinacce con acqua subito dopo la vendemmia e la posca, formata da acqua e vino inacidito (acetum).
Il consumo del vino ebbe la sua espansione in epoca imperiale per lo più nelle zone di produzione e nelle grandi città come Roma dove per le enormi esigenze dovute all'alta densità della popolazione portarono anche ad una distribuzione gratuita di questa bevanda (imperatore Aureliano, ultimi decenni del III sec. d.C.) e al conseguente afflusso di grandi quantità di vino sia italico che di importazione. I prezzi andavano dai 30 denari al sestiario (0,54 l) per i vini pregiati (Falernum, Sorrentinum, Tiburtinum), ai 16 denari al sestiario per i vini di media qualità, agli 8 denari per i vini di basso pregio.
Il consumo medio di vino in un anno è stato calcolato in 140 - 180 litri a persona: questo grande consumo si pensa fosse dovuto anche al grande apporto calorifero che dava alla dieta romana, costituita in gran parte da cereali e vegetali.
da Cultura-Barocca